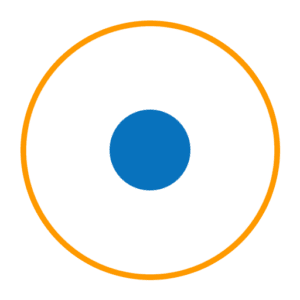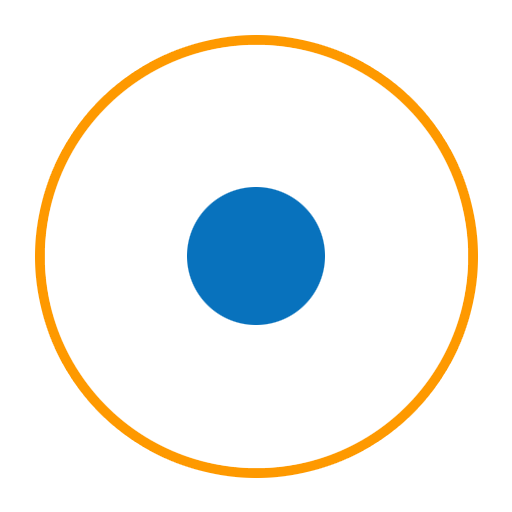Cambiano nome le rivoluzioni jihadiste promosse dall’occidente e ora si chiamano periodi di transizione
Mar Morto (Giordania) – Non chiamatele più Primavere arabe. Egitto, Tunisia, Libia, Marocco, Giordania e Yemen sono “Paesi in transizione”. Non più la poesia di un nome pieno di promesse ma una definizione scientifica più adatta alla difficile realtà: la transizione è una condizione di mezzo, potrebbe anche fallire.
Più delle rivolte di piazza, della sfida salafita, del militarismo e delle resistenze dei vecchi regimi, la minaccia più grave al superamento con successo della fase di transizione, è economica. Ed è su questo fronte che alle porte del Medio Oriente si addensa una tempesta perfetta: dopo le rivolte l’aspettativa delle opinioni pubbliche è alta, i nuovi governi faticano a imporre le riforme necessarie, i conflitti locali non si attenuano, la crisi europea si riflette sulla regione, gli scenari energetici stanno cambiando fino al punto di non escludere uno shock petrolifero.
Sul piano statistico le cose non sembrano drammatiche. Secondo il nuovo Outlook regionale del Fondo Monetario Internazionale, del quale si è parlato qui, al World Economic Forum sulla riva giordana del Mar Morto, nel 2012 la crescita è stata del 5,7% nei Paesi esportatori di petrolio (il forziere del Medio Oriente) e del 2,7 negli importatori; nel 2013 sarà del 3,2 e del 3; l’anno prossimo del 3,7 e del 3,6%.
Poiché quelli privi di risorse energetiche sono i Paesi dove erano esplose le Primavere – l’unica eccezione è la Libia – un incremento di tre punti è quasi miracoloso. Ma è l’equivalente mediorientale della “crescita hindù”, come Amartya Sen un tempo chiamava lo sviluppo costante ma non sufficiente per fare uscire l’India dal suo stato di povertà. Più della metà della popolazione del Medio Oriente arabo (380 milioni, erano 247 milioni nel 1990) ha meno di 25 anni. In questo decennio devono essere creati 75 milioni di nuovi posti di lavoro, cioè il 40% in più di quelli esistenti. E questo spiega più di ogni altra considerazione le cause delle Primavere arabe.
Esistono alcuni limiti strutturali apparentemente impossibili da riformare: prima e dopo le rivolte. La piccola e media impresa rappresenta i due terzi dell’imprenditoria privata formale e garantisce l’80% dell’impiego. Ma riesce a raccogliere solo l’8% del credito. L’interscambio all’interno della regione è l’8,7% dei suoi commerci: in Europa è il 63,7 e il 66,8 nel Pacifico asiatico.
Nel 2012 i sussidi all’energia – 240 miliardi, cioè l’8,5% del Pil mediorientale – hanno drenato il 22% delle risorse pubbliche. Quelli alimentari sono stati solo lo 0,7%. E’ stato provato che i sussidi non sono lo strumento migliore proteggere le fasce sociali più deboli, tuttavia i governi in transizione hanno gravi difficoltà a ristrutturarli: il credito da 4,8 miliardi del Fondo Monetario concordato con l’Egitto è congelato perché il presidente Morsi non riesce a completare la riforma sui sussidi.
Sempre nel 2011 i venture capitalist mediorientali erano stati in grado di raccogliere fondi per finanziare 65 startup. Nello stesso anno in Israele – meno di nove milioni di abitanti – ne sono nate 546. Fino ad ora questi limiti strutturali venivano bilanciati dalla ricchezza dei Paesi esportatori, soprattutto dai regni e dagli emirati del Consiglio di cooperazione del Golfo che nel 2012 avevano accumulato un surplus da 440 miliardi di dollari.
Ma il quadro sta cambiando, come testimonia l’outlook del Fondo monetario: le incertezze politiche regionali “fino ad ora non hanno avuto un impatto materiale sulla produzione degli idrocarburi, ma a breve termine un deterioramento della sicurezza o l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche potrebbe influire sulle esportazioni. A medio termine l’aumento dei costi per la sicurezza e un clima meno attraente per gli investimenti potrebbero ridurre il ritmo col quale le forniture si espandono. I rischi a lungo termine per il prezzo degli idrocarburi comprendono la moltiplicazione in altre parti del mondo della rivoluzione del shale americano”.
La ripresa a pieno regime della produzione petrolifera in Libia, è stata una delle ragioni del 5,7% di crescita dei Paesi esportatori nel 2012. Ad eccezione del Bahrein, nessun altro è stato raggiunto dal vento elle Primavere arabe. Ma anche questo ha avuto un costo: sauditi, Qatar ed Emirati hanno moltiplicato la spesa sociale. Aumento degli stipendi per militari e dipendenti pubblici, case popolari, studi gratuiti fino all’università, nuovi sussidi.
Ma il forziere non è senza fondo: il surplus dei Paesi petroliferi quest’anno si ridurrà a 370 miliardi e continuerà a scendere, seguendo l’andamento dei prezzi del barile. In Arabia Saudita il surplus è quasi azzerato. “Molti Paesi esportatori”, ha spiegato al World Economic Forum Masood Ahmed, il direttore del dipartimento mediorientale del Fondo Monetario, “stanno affrontando spese che possono essere sostenute solo con gli attuali livelli di produzione e di prezzi”. Ma la crisi europea, il rallentamento economico cinese, le promesse dello shale americano e le incertezze geopolitiche non sono una garanzia di rendimento e prezzi corposi.