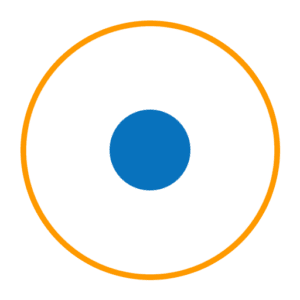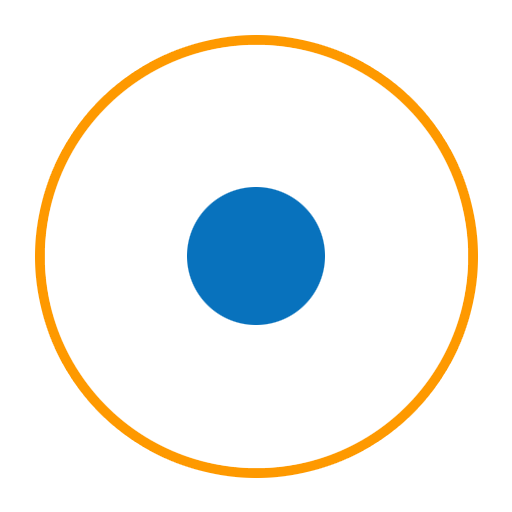L’Italia ha perso l’appuntamento decisivo
L’Italia ha perso l’appuntamento decisivo
Nell’Opinione pubblicata da “L’Indro” lo scorso 29 dicembre, dopo l’annuncio dell’accordo tra la francese Edf e l’italiana Edison, di fatto acquisita dal colosso pubblico parigino, si interpretava l’avvenimento come uno degli scenari più interessanti della nuova geopolitica europea. Una opinione, la nostra, confermata da Henry Proglio, presidente e amministratore delegato di Edf, nel corso di un’intervista a ’Il Sole 24 Ore’.
Alla domanda dell’intervistatore su i perché della decisione del suo gruppo energetico rispondeva senza mezzi termini: “L’Italia ha una rilevanza geostrategica cruciale, all’incrocio tra Africa del Nord, Europa del Sud e Asia centrale. Tant’è che tutti i gasdotti arrivano, passano o passeranno per l’Italia. Per questo abbiamo individuato in Edison una bellissima piattaforma da valorizzare e che, d’ora in avanti, potrà contare sulle capacità di ricerca e la potenza di fuoco che Edf possiede con Gf il colosso gasiero che fa capo al nostro gruppo e che è impegnato con tutte le sue forze in vari paesi mediterranei dove, tra l’altro è meglio presentarsi come italiani che non come francesi”.
A parte questa ammissione di convenienza politica, vi è anche uno scenario innovativo della collaborazione tra nazioni per affrontare il futuro energetico dell’Europa. Cerchiamo di spiegare il grande ’gioco’ del gas che, dai primi del duemila a oggi, è diventato la cartina di tornasole per giudicare le strategie dello sviluppo.
Sul tavolo vi sono tre protagonisti: il gas, naturalmente, la Russia con le più grandi riserve di gas fino ad oggi conosciute e le nazioni europee, in parte attente alle indicazioni strategiche della Ue e in parte tentate da scelte autonome.
Tenuto conto che il nucleare è in declino e che le cosiddette energie rinnovabili (sole, vento, acqua ed altre più o meno utilizzabili) sono ancora in una fase che oggettivamente può essere definita iniziale e che forse sarà risolutiva nella seconda metà del secolo il combustibile per ora meno inquinante e più facile da utilizzare è proprio il gas. Da oggi e almeno per altri 30 anni centrali elettriche, riscaldamento civile, autotrazione troveranno una risposta accettabile dal gas naturale. Per quella data il 25% dell’energia totale consumabile sarà suo appannaggio. In oltre ha dalla sua una fortuna in più: il probabile declino del petrolio e la crescente ostilità nei confronti del carbone, anch’esso combustibile molto diffuso e di lunga durata, ma altamente inquinante.
Non meraviglia che nel ’gioco’ europeo sia entrata ancor più pesantemente che nel passato la Russia. Oggi la patria di Putin può contare su riserve accertate di almeno 1100 miliardi di metri cubi. Forte di questa posizione Mosca ha messo in campo una crescita sempre più costante dell’offerta di questa sua potenzialità . Una politica che deve. tuttavia, superare timori non infondati di quei Paesi che vedono nel primato russo una rischio per la loro indipendenza energetica e che alimentano, come è quasi sempre accaduto tra le nazioni europee, voglie di contratti in esclusiva che bypassino le decisioni comuni. Nell’ultimo decennio questa voglia di muoversi come tanti cani sciolti ha rallentato i traguardi che Mosca si era posta per lo crescita delle sue esportazioni di gas naturale. Per la Russia questa fonte, tornata prepotentemente attuale è da sempre la sua maggior risorsa economica che le consente di continuare ad essere uno dei protagonisti mondiali dell’energia. In più il suo mercato più appetibile è proprio quello europeo.
Da sempre importano gas naturale in grande quantità l’Italia, la Germania e la Francia. Sono indipendenti almeno per ora, solamente Inghilterra, Olanda e Norvegia (queste ultime due sono anche esportatrici). A far entrare in fibrillazione energetica due grandi nazioni come Francia e Germania è stato il disastro nucleare giapponese, che ha indotto i due paesi più nuclearizzati d’Europa a vedere nel gas metano il sostituto più naturale all’atomo.
La Francia oggi non è più certa di poter continuare al ritmo di prima la sua scelta nucleare. E’ probabile che al momento di mettere a riposo alcune delle sue 52 centrali nucleari (che le hanno permesso una produzione di energia elettrica in assoluta sicurezza strategica e a costi ammortizzati in anni di attività) sia costretta a cambiare tipo di combustibile, vale a dire fare ricorso sempre più massiccio al gas. A sua volta la Germania ha promesso di chiudere le centrali nucleari una dopo l’altra secondo una tempistica ravvicinata e di non aprirne di nuove. Ma per la nazione industriale più sviluppata del Continente europeo non saranno certo le rinnovabili a sostituire il nucleare. Non potrà esserlo neppure il carbone, fonte tradizionale del paese, ma altamente inquinante. Se ne ricava che la sua scelta, battendo in velocità il resto d’Europa, sia stato il potenziamento delle proprie importazioni di gas dalla Russia. L’8 novembre scorso è stato inaugurato un nuovo gasdotto gigante, il Nord Stream, che congiunge la Siberia, attraverso il mar Baltico, alla Germania del Nord.
Il Nord Stream, pensato nel 2005 in sei anni è diventato una realtà, con buona pace delle diverse ipotesi messe in campo una dopo l’altra da quasi tutti i potenziali clienti di Mosca. Le incertezze non sono una caratteristica del governo tedesco. Nel frattempo la Ue, persa nei suoi intricati conciliaboli di Bruxelles continua, ormai da oltre un decennio, una diversa politica che si basa su due grandi gasdotti sempre ricordati, ma mai messi in cantiere. Il primo, chiamato Nabucco, aveva avuto il sostegno dagli Usa perchè avrebbe frenato le ambizioni di Putin e avrebbe fatto a meno del suo gas, per acquistarlo direttamente dalle riserve di atzeri e turkmeni.
Il secondo, noto come South Stream, e a cui partecipano sia l’Italia, con Eni, sia la Francia con Gf (controllata da Edf) unirà i grandi giacimenti del Nord della Russia alla Bulgaria attraversando il Mar Nero diramandosi poi verso nord passando per la Serbia e l’Austria e verso sud attraversando la Grecia ed entrando in Italia all’altezza della Puglia. I suoi pregi sono soprattutto due: bypasserà l’Ucraina, collo di bottiglia per i rifornimenti di gas russo spesso sotto ricatto, e potrà trasportare a pieno regime 63 miliardi di metri cubi di metano. Ha, tuttavia, un difetto: è il più costoso di tutti (15,5 miliardi di dollari, contro i 7,9 del Nabucco, e il 7,4 del North Stream). In più, come per il suo quasi omonimo del Nord, dovrà accettare una pesante partecipazione di Gazprom, il gigante societario russo saldamente fedele a Putin e vera chiave del suo potere politico.
Tracciata questa grande carta geografica del gas, in parte realizzata e in parte di la da venire, quale è la situazione dell’Italia per il suo futuro energetico, da sempre legato al gas naturale fin dai tempi di Enrico Mattei, fondatore dell’Eni? Si può giudicare equilibrato sulle quantità, ma forse debole su una diversificazione geografica che in futuro ravvicinato potrebbe impensierire. L’Italia consuma gas naturale per 83 miliardi di metri cubi il 90% dei quali è importato da paesi che non appartengono alla Ue: 34,4% Algeria, 30% Russia, 12,5% Libia e Egitto. In aggiunta va ricordato che l’88% di queste importazioni avviene attraverso gasdotti (unica eccezione l’Egitto) . Detto questo, fatte salve le perplessità per lo stretto legame con la Russia, che se dovesse saltare anche solo in parte ci metterebbe veramente in ginocchio, vi è tutta l’area del Nord Africa che sta vivendo la cosiddetta ’Primavera araba’ e che potrebbe lentamente trasformarsi in un ’Autunno arabo’. Nel frattempo abbiamo acquisito una capacità tecnica nel sistema gas che ci ha collocato ai primi posti, non solo in Europa, ma nel mondo intero. I tubi del Nord Strema nel fondo del Baltico sono stati posati dalla Saipem del gruppo Eni con due navi, Castoro 6 e Castoro 10, le più tecnologicamente avanzate nel mondo. Le stesse unità hanno congiunto l’Algeria alla Spagna e la Russia, sotto il Mar Nero, alla Turchia.
Una via di uscita potrebbe essere quella auspicata anche dalla francese Edf attraverso la ex-italiana Edison: ridurre il peso dei gasdotti e potenziare il trasporto via nave di Gnl (Gas naturale liquefatto). Ma qui siamo in Italia. Il tanto decantato ’hub gasiero’ Mediterraneo previsto più di 10 anni fa e che avrebbe dovuto essere costituito da 11 complessi per la rigassificazione del Gnl collocati lungo le nostre coste e poi utilizzato come sicuro distributore per il resto d’Europa, è fermo a soli 2 impianti. Uno, quello della Edison, da poco in funzione a pieno regime e il secondo, quello della Snam a Panigalia, messo in cantiere nel 1967 e realizzato nel 1970. Il che vuol dire la bellezza di quarantadue anni fa. Il resto del progetto è ancora impantanato tra i divieti e i distinguo con cui si confrontano ambientalisti, costruttori di impianti, politiche regionali e ambizioni di singoli comuni rivieraschi.