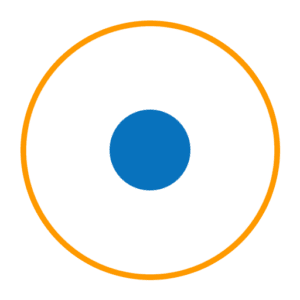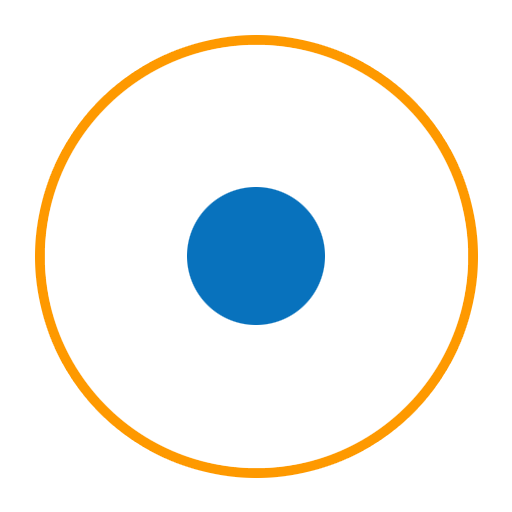Di solito si cominciano questi articoli con un solenne e retorico “addio”. Ma in questo caso forse sarebbe più opportuno un sano brindisi ad un autore che la morte l’ha sconfitta da tempo, entrando nel gotha degli immortali della letteratura e che oggi ha deciso, con dispiacere di tutti, di andare a conoscere di persona i paesi al di là dei confini dell’autunno e di Halloween che lo hanno ispirato nella sua vita d’artista.
Ray Bradbury, nato nel 1920 in quell’Illinois che sarà luogo d’ambientazione di moltissimi suoi racconti e romanzi, ha indubbiamente conquistato quella “vita eterna” che lo ha affascinato tanto da farne il tema portante di molti dei suoi libri, da Addio all’Estate a Il Popolo d’Autunno.
L’ha conquistata con i suoi racconti di fantascienza con cui ha rigenerato e reinventato un genere, a partire dall’acclamatissimo Cronache Marziane fino ai racconti de I Fiori di Marte. L’ha conquistata coi suoi romanzi onirici che spesso sconfinano nell’horror e nel gotico, storie in cui sogni, incubi, passato, futuro, vicino e lontano si intrecciano e aprono ognuno le porte agli altri e che spesso hanno come sfondo la notte di Halloween, la magica notte in cui le porte dei mondi si spalancano e in cui i mondi stessi si intersecano.
Ma soprattutto l’ha conquistata con il suo capolavoro assoluto, quel Fahrenheit 451, apparso in Italia per la prima volta col titolo Gli Anni della Fenice e purtroppo massacrato dalla pessima resa cinematografica di un Truffaut decisamente poco in forma. Un romanzo di distopia talmente iconico da essere diventato emblema, assieme al 1984 di Orwell, dell’intero genere.
Un romanzo ricco di sentimento e amore per la letteratura che descrive un mondo in cui i libri sono vietati, un romanzo denso di una poesia e di un romanticismo che cambieranno per sempre il portagonista Guy Montag ma soprattutto una previsione lucida, geniale e purtroppo indovinatissima di un mondo a noi oramai fin troppo vicino. Il mondo dell’era dell’informazione, un mondo in cui siamo imbottiti e bombardati da dati e informazioni in tempo reale ma che di fatto ci fanno essere fermi e immobili, passivi al flusso di dati impersonali che diamo per veri, che ci hanno tolto il gusto della ricerca e della critica. Un mondo dove “cultura” vuol dire sciorinare questi dati a memoria, un mondo in cui il programma culturale è il quiz con domande di geografia o sport grazie alle quali speriamo di diventare milionari. «Offri al popolo gare che si possano vincere ricordando le parole di canzoni molto popolari, o il nome delle capitali dei vari Stati dell’Unione o la quantità di grano che lo Iowa ha prodotto l’anno passato. Riempi loro il cranio di dati non combustibili, imbottiscili di fatti al punto che non si potranno neanche più muovere tanto sono pieni, ma sicuri di essere veramente ben informati.
Dopo di che avranno la certezza di pensare, la sensazione del movimento, quando in realtà sono fermi come un macigno. E saranno felici perché fatti di questo genere sono sempre gli stessi. Non dar loro niente di scivoloso e ambiguo come la filosofia o la sociologia affinché possano pescare con questi ami fatti ch’è meglio restino dove si trovano. Con ami simili pescheranno la malinconia e la tristezza». Il mondo dei reality e della televisione a mille canali davanti a cui perdiamo il nostro “tempo rimanente”, con la tv interattiva che ci fa credere protagonisti agenti di ciò che vediamo sullo schermo quando invece siamo solo zombi decerebrati e lobotomizzati da un monitor.
Un mondo che ama dividere i popoli in minoranze da tutelare preservando “le libertà” per far sì di tenere ben lontana LA libertà: «Consideriamo ora le minoranze in seno alla nostra civiltà. Più numerosa la popolazione, maggiori le minoranze. Non pestare i piedi ai cinofili, ai maniaci dei gatti, ai medici, agli avvocati, ai mercanti, ai pezzi grossi, ai mormoni, battisti, unitarii, cinesi della seconda generazione, oriundi svedesi, italiani, tedeschi, nativi del Texas, brooklyniani, irlandesi, oriundi dell’Oregon o del Messico. (…) Più vasto il mercato, Montag, meno le controversie che ti conviene comporre, ricordatelo! Tutte le minoranze, fino alle infime, vanno tenute bene, col loro bagnetto ogni mattina». Un mondo dove la delazione sia tra nemici che tra consanguinei è incoraggiata e l’invidia e l’odio tra vicini sono rinfocolati. Un mondo come questo dove, se la lettura ancora non è vietata, è resa inutile, come aveva previsto lo stesso Bradbury in una sua intervista di qualche anno fa.
Ma forse l’importanza e la bellezza del romanzo stanno principalmente nel fatto, più unico che raro nel genere distopico, che Bradbury offre una via di scampo, una soluzione alla prigione autoimposta dell’ignoranza gretta e bassa del mondo. E non lo fa tramite un lieto fine improbabile o una speranza millenarista e messianica promettendo un futuro brillante né soprattutto con la certezza che prima o poi qualcosa cambierà. Lo fa affermando due concetti semplici eppure essenziali per la riuscita della rivoluzione culturale che può piegare le nostre sbarre. Il primo è la fanciullezza disinteressata, la purezza bambina e gioiosa rappresentata dalla giovane Clarisse McClellan che risveglia nel freddo Montag quel “disperato amore” che riaccenderà un fuoco vero, puro e creatore e non un fuoco chimico al cherosene utile solo a distruggere. Il secondo è che non basta leggere i libri per farne armi di costruzione di mondi e cultura: bisogna ESSERE i libri che si legge, incarnare le idee che si leggono affinché non restino stampate su carta ma vengano vivificate e attuate. In poche parole, essere cultura che diventa azione.