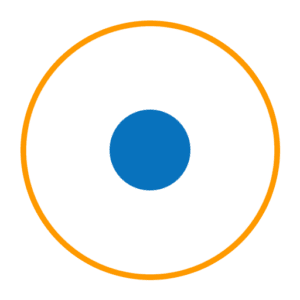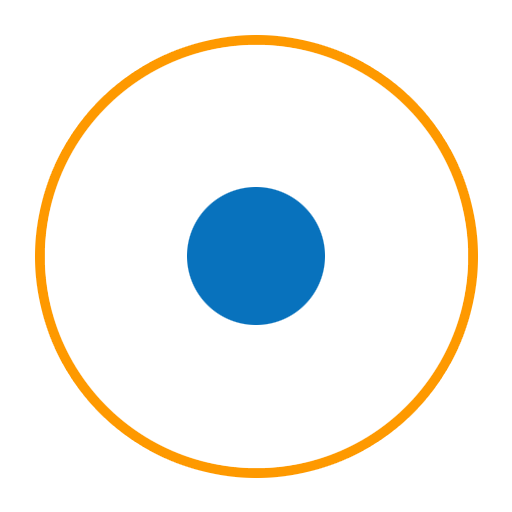Storie di immigrati cinesi che si stanno rapidamente uniformando all’evoluzione obbligata dei sistemi marxisti: il capitalismo più avanzato
 Ormai la Cina cambia di nuovo pelle,passata velocemente dall’”impero celeste” al comunismo, apre la via ad una società industriale con uno sviluppo verticale. Ex contadini che diventano imprenditori affermati,proprietari di piccole industrie e aperti al commercio internazionale. Sull’evoluzione dell’Oriente le parole di Evola furono profetiche come sempre.
Ormai la Cina cambia di nuovo pelle,passata velocemente dall’”impero celeste” al comunismo, apre la via ad una società industriale con uno sviluppo verticale. Ex contadini che diventano imprenditori affermati,proprietari di piccole industrie e aperti al commercio internazionale. Sull’evoluzione dell’Oriente le parole di Evola furono profetiche come sempre.
A 20 anni Shengde Sun era un contadino povero in una comune rurale nella regione del Zhejiang, a sud di Shanghai. A 30, sbarcato in Italia, lavorava come cuoco in un ristorante cinese di Biella, oppresso dal freddo e dalla nebbia. Oggi, alla vigilia dei 50 anni, Sun è un ricco e rispettato imprenditore. Dai suoi uffici con grandi finestre sulla romana piazza Vittorio, cuore dell’Esquilino, il rione considerato la Chinatown della capitale, controlla un’impresa di import-export di abbigliamento, un’agenzia di servizi che impiega notai, avvocati e commercialisti italiani, quattro ristoranti. In più ha interessi nell’immobiliare ed è socio, in Cina, di una fabbrica con 4 mila operai che visita, accompagnato dal suo stilista, almeno una volta al mese. Ride: «Io sono operaio. Grande lavoratore. Non come voi italiani: sabato vacanza, domenica vado fuori…. Io lavoro sempre. Così sono cresciuto a poco a poco. Non come una bomba».
Immagine curiosa: proprio di esplosione dell’imprenditoria cinese in Italia cominciano a parlare alcuni osservatori. Come la Cgia di Mestre, associazione di artigiani e piccole imprese. In tre anni, tra il 2000 e il 2003, ha segnalato, il numero delle imprese cinesi è aumentato del 68,6 per cento. Concorda l’ufficio studi della Camera di commercio di Milano, indicando un’espansione verso sud: «È febbre gialla: a Napoli si passa da 60 imprese nel 2000 a 549 nel 2004, a Lecce da 9 a 111, a Reggio Calabria da 1 a 97». Oggi gli immigrati dalla Cina figurano al terzo posto nella classifica degli imprenditori extracomunitari in Italia, dopo svizzeri e marocchini. Mentre sono solo quinti nelle statistiche generali dell’immigrazione.
Su 97.757 cinesi registrati ufficialmente in Italia (dati Caritas), 24.961, uno su quattro, ha un’attività in proprio. E non solo ristoranti o laboratori d’abbigliamento o borsette in cui si lavora 16 ore al giorno, con i vetri oscurati, spesso impiegando clandestini e, a volte, anche bambini. «Da alcuni anni nuove professioni caratterizzano i cinesi in Italia» ha scritto, in un saggio sulla rivista Aspenia, Antonella Ceccagno, docente di lingua e letteratura cinese all’Università di Bologna. «Questo, insieme con lo sviluppo sorprendente delle attività più tradizionali, indica quanto la comunità italiana degli xin yimin (i migranti) sia ormai variegata, stratificata e sia entrata in una fase di maturità dinamica».
A Milano Cinzia Hu, 33 anni, laurea in economia alla Bocconi, ha aperto uno studio di commercialista che impiega due ragionieri italiani e tre cinesi e ha clientela mista. Racconta: «Sono arrivata dalla Cina a 11 anni. Ho imparato l’italiano prima dei miei genitori e ho fatto l’interprete per loro. Ho frequentato ragioneria, poi l’università, sempre lavorando nel ristorante dei miei. Un giorno ne ho aperto uno». Ma Cinzia Hu continuava a fare i conti per i parenti e l’interprete per gli amici nell’acquisto di case e negozi. Tutto gratis. Finché suo marito, Marco Ji, le ha suggerito di farsi pagare ed è nato lo studio. Spiega Luigi Sun, 50 anni, portavoce della comunità cinese di Milano, la più antica d’Italia: «I nostri migranti vogliono una sola cosa: mettersi in proprio».
A Milano come a Napoli. Ecco la storia di Zuogan Jiang, 33 anni, sposato con una connazionale, due figli, proprietario di un’azienda con 15 operai a Terzigno, nell’entroterra vesuviano: «In Cina facevo l’insegnante. Sono ven