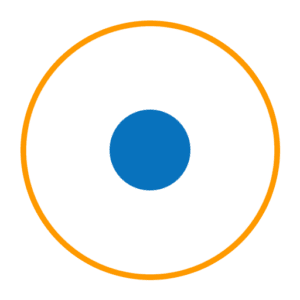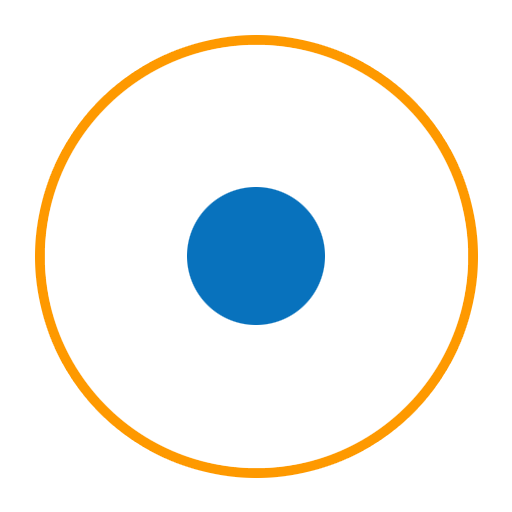La fortuna è come una ruota; che si prova, signor colonnello, quando gira e non c’è più la certezza dell’inviolabilità?
Il luccichio che gli colora gli occhi assomiglia a quello di 35 anni fa, quando, da capitano dei carabinieri, uomo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, balzò dalla sua 124 bianca e afferrò per il collo il brigatista Alberto Franceschini prima che mettesse mano alla pistola appesa alla cintola, col colpo in canna. C’era anche Renato Curcio sull’auto speronata a Orbassano, vicino a Pinerolo.
Era l’otto settembre del 1974. I capelli erano di più, scarmigliati e neri. Oggi sono bianchi, ordinati. I tratti del volto, però, sono identici. “Allora era una scarica di adrenalina a muovermi — spiega il capitano nel frattempo diventato colonnello — ora i miei occhi raccontano solo di tanta rabbia e di estrema delusione… Ho servito il mio Paese per quarantacinque anni, venti con la divisa dell’Arma cucita sulla pelle e gli altri venticinque passati nei servizi segreti. A proteggere la gente. Mai avrei immaginato di andare in pensione con una infamante sentenza di condanna a tre anni per favoreggiamento personale in un sequestro, mai… Ho pianto, non mi vergogno a dirlo. Allucinante e inaudito, ciò che è potuto accadere. Ma sono un figlio di questo Stato e in questo Stato di diritto credo, ho lavorato al fianco di eccellenti magistrati e giudici, rispetto dunque il verdetto con la certezza che ho dentro di poterlo sovvertire in appello. Ma non è facile farsene una ragione. Mi si creda… ho speso una vita per la giustizia”.
Tira finalmente il fiato, questo carabiniere di Dalla Chiesa. La sentenza che l’ha condannato è di mercoledì scorso, il processo è quello ai vertici del Sismi e della Cia per il sequestro a Milano dell’ex imam Abu Omar. L’ombrello di un discusso segreto di stato ha preservato il capo dei capi, Nicolò Pollari, ha preservato il suo diretto superiore, Marco Mancini, ma non lui. Che nell’indagine entra soltanto per avere passato il telefonino di servizio, così come richiestogli da Mancini, a un altro collega del Sismi, il generale Gustavo Pignero, già gravemente ammalato e ora scomparso. Mentre il giudice Oscar Magi leggeva il verdetto, Seno era in fondo all’aula. Solo. Lontano dai fotografi. Una valigetta in mano. “Ho obbedito a un ordine legittimo — ribadisce il colonnello — non ha mai saputo nulla del sequestro di Abu Omar se non dai giornali, e questo è il risultato… una follia del sistema. Chi imputa al Sismi un lavoro sbagliato e malfatto come la vicenda Abu Omar sbaglia di grosso, nessuno di noi avrebbe agito in quel modo…”.
Abita a Roma, Luciano Seno. Non ha figli. Le sue origini sono piemontesi. E lo dice con un certo orgoglio perché è proprio lì, in Piemonte, che sono nati i carabinieri. Ha arrestato Curcio e Franceschini, ha sgominato la banda XXII Ottobre e catturato i sequestratori di Sergio Gadolla. E’ stato lui, ancora una volta, a mettere le manette all’assassino di Milena Sutter, la figlia tredicenne dell’industriale della famosa cera per pavimenti sparita nel nulla il pomeriggio del 6 maggio del 1971, all’uscita da una scuola svizzera, e restituita dal mare di Genova due settimane più tardi.
Dalla Chiesa l’aveva visto giovane ufficiale al battaglione carabinieri di Milano, caserma Lamarmora, dietro a Palazzo di Giustizia. E appena lo incontrò quasi per caso a Genova, primi anni ’70, se lo portò a Torino per dare vita al primo Nucleo speciale antiterrorismo. “I nostri giorni e le nostre notti non hanno più avuto tempo per noi, per i nostri cari. Nulla che non fosse il lavoro, da battere c’erano le Brigate Rosse. E il mio generale era sempre in mezzo a noi”. Ricorda, Seno, di una informativa da mandare al giudice istruttore con urgenza. “Scrivevamo di notte, e alle quattro Dalla Chiesa ebbe un piccolo cedimento… Noi restammo fermi, in silenzio… Dopo tre minuti Dalla Chiesa si risvegliò e ci fissò uno per uno… “Ragazzi- disse – che cosa credete, anche un generale si può abbioccare, forza che finiamo…”.
La foto dell’arresto di Franceschini preso per il collo ha fatto il giro del mondo.
“Pochi sanno che a scattarla fu un carabiniere che Dalla Chiesa ci aveva messo alle costole per proteggerci… Incredibile, quel pomeriggio. Io con la mia 124 privata e un collega al volante restai senza comunicazione radio per un maledetto guasto. Ero isolato dietro a Curcio e Franceschini… Li seguii fino a quando arrivammo a un passaggio a livello… ebbi paura di restare dietro alla sbarra e di perderli, allora ordinai al mio carabiniere di tamponarli… scendemmo per constatare il danno ma Franceschini fiutò subito l’odore di trappola e tentò la fuga. Curcio restò immobile alla guida. Agii in fretta. Un balzo… poi vidi spuntare da una siepe una macchina fotografica… Ammanettai anche Curcio e gridai al collega di bloccare quell’uomo oltre il cespuglio… pensai a un brigatista, ora ci spara. Il mio ragazzo corse come una lepre, rovinò sul poveretto e lo stese con un cazzotto in bocca… poi quello si mise a gridare …”fermati, che fai, sono anche io un carabiniere”…
E se lo portò anche a Roma, il generale. “Lo aveva chiamato Andreotti e lui volle ancora me e i suoi ragazzi — ricorda il colonnello Seno — eravamo una decina ma facemmo lo stesso il miracolo… un bravo carabiniere riuscì a infiltrarsi nel covo di via Volsci e prese la lista di tutti gli iscritti al “potrop”, a Partito operaio. Scoprimmo tutti…”. Se gli chiedi se è stato un bravo carabiniere, il colonnello ritrova il sorriso. “Per me parlano le indagini, io non devo dire niente…”. Si sfrega il mento, si aggiusta la giacca, il colonnello. E prima di salutare sussurra poche parole. “Fa male vedersi trattare come un delinquente”.
La ruota gira signor colonnello. Sapesse a quanti ragazzi fece male esser trattati da delinquenti solo perché non condividevano i sacri valori della Resistenza o della borghesia…